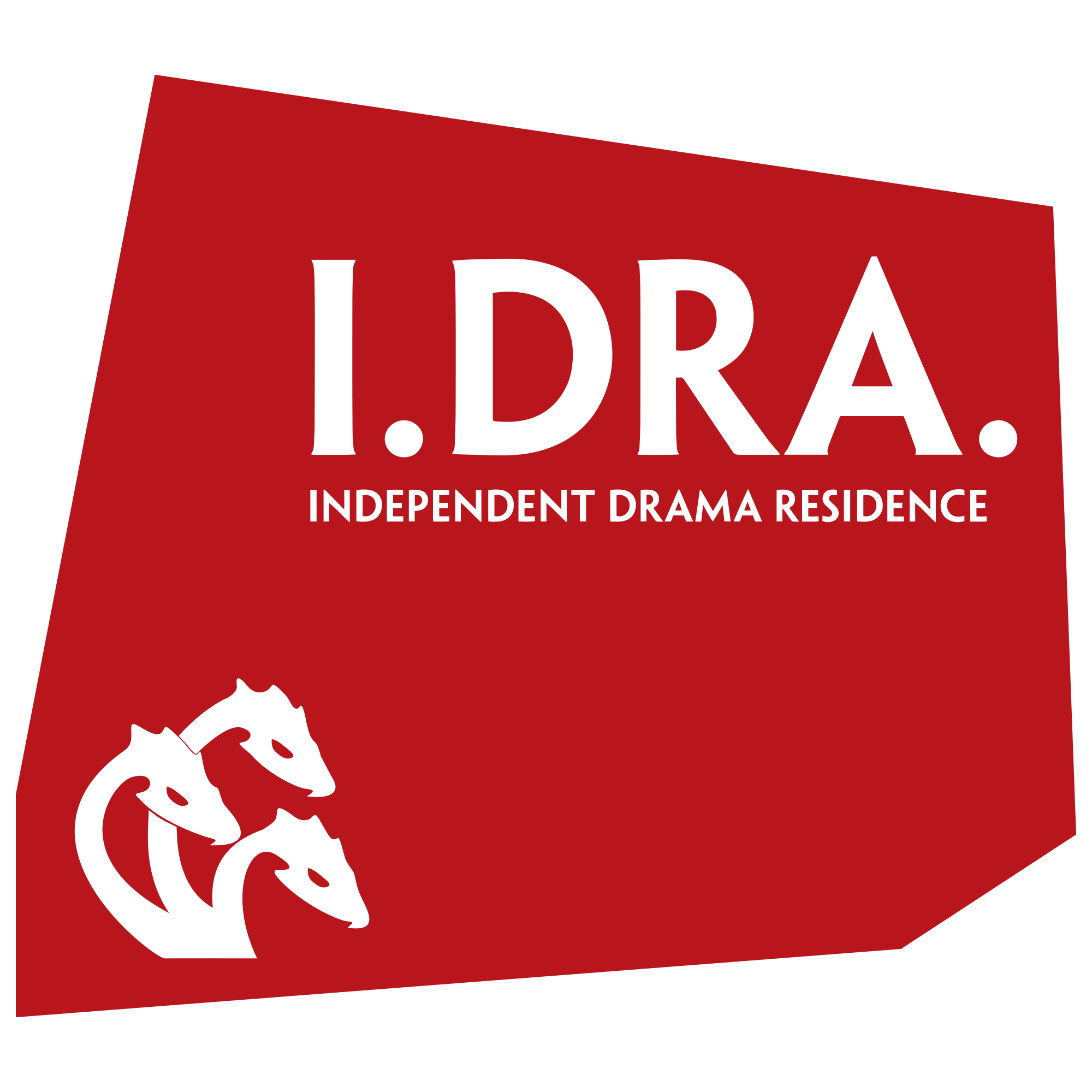Che fare? si chiedeva Nikolaj G. Chernyshevsky, immaginando nel suo famoso romanzo pubblicato nel 1905, le relazioni umane ricostruite a partire dall’esperienza collettiva e dalla critica radicale delle convenzioni borghesi. Se trasferissimo questa prospettiva alla politica culturale, la domanda diventerebbe: come può una comunità riorganizzare le proprie istituzioni affinché l’arte sia al servizio di un nuovo pubblico e non delle logiche di mercato? O meglio ancora, come può diventare un luogo di sperimentazione in cui le istituzioni vengono ricostruite per il valore pubblico a scapito delle logiche di mercato?
FNSV 2025: un caso studio italiano di politica culturale europea
Il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) italiano 2025 è stato istituito con un nuovo decreto ministeriale e una serie di atti della Direzione Generale. Per i lettori e le lettrici fuori dall’Italia: il fondo FNSV copre teatro, danza, musica, circo e il settore multidisciplinare.
Prendiamo in considerazione tre punti di vista. Ateatro definisce i risultati un “cambiamento senza cambiamento”, sottolineando una crescita marginale e una mappa definita più dalla ridistribuzione dei fondi che dagli investimenti fatti. Segnala la diminuzione dei festival e le frizioni all’interno delle commissioni. Teatro e Critica (Alessandro Toppi) allarga le argomentazioni al sottofinanziamento cronico del settore che trasforma ogni triennio in una battaglia in un clima di insufficienza economica. Delinea un orientamento manageriale che premia più il volume di pubblico e le variabili finanziarie rispetto alla ricerca e sperimentazione artistica. C.Re.S.Co. affronta il discorso a livello strutturale chiedendo trasparenza, equità tra i territori e criteri verificabili. La conferenza indetta alla Camera dei Deputati inquadra la necessità di indicatori comparabili e di un comportamento più limpido da parte della commissione.
A livello istituzionale, il FNSV è una catena di atti giuridici in cui le controversie vertono sul decreto in vigore. Per i professionisti e le professioniste non italiani, ciò significa affrontare prima i documenti, poi le testimonianze. Il caso Pergola/Teatro della Toscana è diventato lo “stress test” nazionale: un declassamento dello status del Teatro interpretato come politico da alcuni, conforme da altri. I media generalisti di destra hanno enfatizzato la correttezza procedurale di quanto accaduto rispetto alle narrative di guerra culturale.
La situazione vede da un lato i festival, colonna portante della ricerca e sviluppo, vulnerabili; dall’altro lato i sistemi culturali locali rimodellati dalle nuove assegnazioni dei fondi. Dalle opinioni emerge una linea comune: la necessità di separare la scarsità (erosione del budget) dalla distribuzione (scelta dei criteri di assegnazione). Il concetto di scarsità provoca la sensazone di operare secondo la linea “mors tua vita mea” mentre la distribuzione spiega i cambiamenti repentini in assenza di nuovi fondi. Le logiche del “new public management” acquisiscono maggiore peso nelle valutazioni e nei controlli: il pubblico e le variabili finanziarie acquisiscono importanza, la sperimentazione artistica e l’accessibilità sociale vengono marginalizzate.
Per l’Europa, il caso italiano è una prova sul piano sia di governance sia finanziaria. I calendari e la stabilità della pianificazione sono essenziali come il totale di una voce di bilancio. L’equilibrio tra territori e l’accessibilità attraverso una precisa progettazione determinano chi può partecipare, non solo chi presenzia. Indicatori verificabili, sensibili al genere e all’inclusione, trasformano le promesse in politiche responsabili. Per i progetti che cercano rilevanza a livello europeo, è necessario partire dagli atti ufficiali, poi aggiungere l’analisi della società civile e la mappatura degli organismi di controllo. Fondamentale è tradurre la complessità in una sintesi di facile comprensione che la cittadinanza e i decisori politici possano utilizzare.
A livello politico, l’attuale governo ha promesso di “cambiare tutto” e di rompere con il passato. Ciò che ne è risultato sembra più un rinnovamento timido che una rottura netta. Si è trattato di un errore di valutazione, dovuto a una burocrazia troppo complessa da piegare? Oppure di una scelta consapevole per guidare le istituzioni con azioni di soft power senza destabilizzare un sistema già fragile? O forse la sfida decisiva si sta spostando su altre leve: bilanci regionali, politica fiscale, sistemi di sponsorizzazione? L’attività di advocacy dovrebbe decidere dove la pressione può produrre cambiamenti: statuti, criteri o un mix più ampio di finanziamenti.
Torniamo a Chernyshevsky: le istituzioni sono modellate dall’esperienza collettiva, non solo dai decreti. Serve costruire competenze che proteggano l’assunzione di rischi e misurino l’inclusione, città per città. Bisogna ancorare i concetti alle prove, in modo che le controversie non si dissolvano in meri argomenti di discussione. Serve promuovere standard che altre istituzioni possano riutilizzare: indicatori sull’accessibilità e sull’uguaglianza, e strumenti di valutazione aperti. Allora la questione diventa pratica, non più slogan. Che fare? La domanda è rivolta a enti come C.Re.S.Co. e AGIS, e a tutti i mediatori europei: dove sta andando la cultura e come possiamo arrestare una deriva commerciale sempre più profonda prima che rimodelli la nostra sfera pubblica?
Articolo scritto dal direttore artistico Davide D’Antonio.
Traduzione dall’inglese