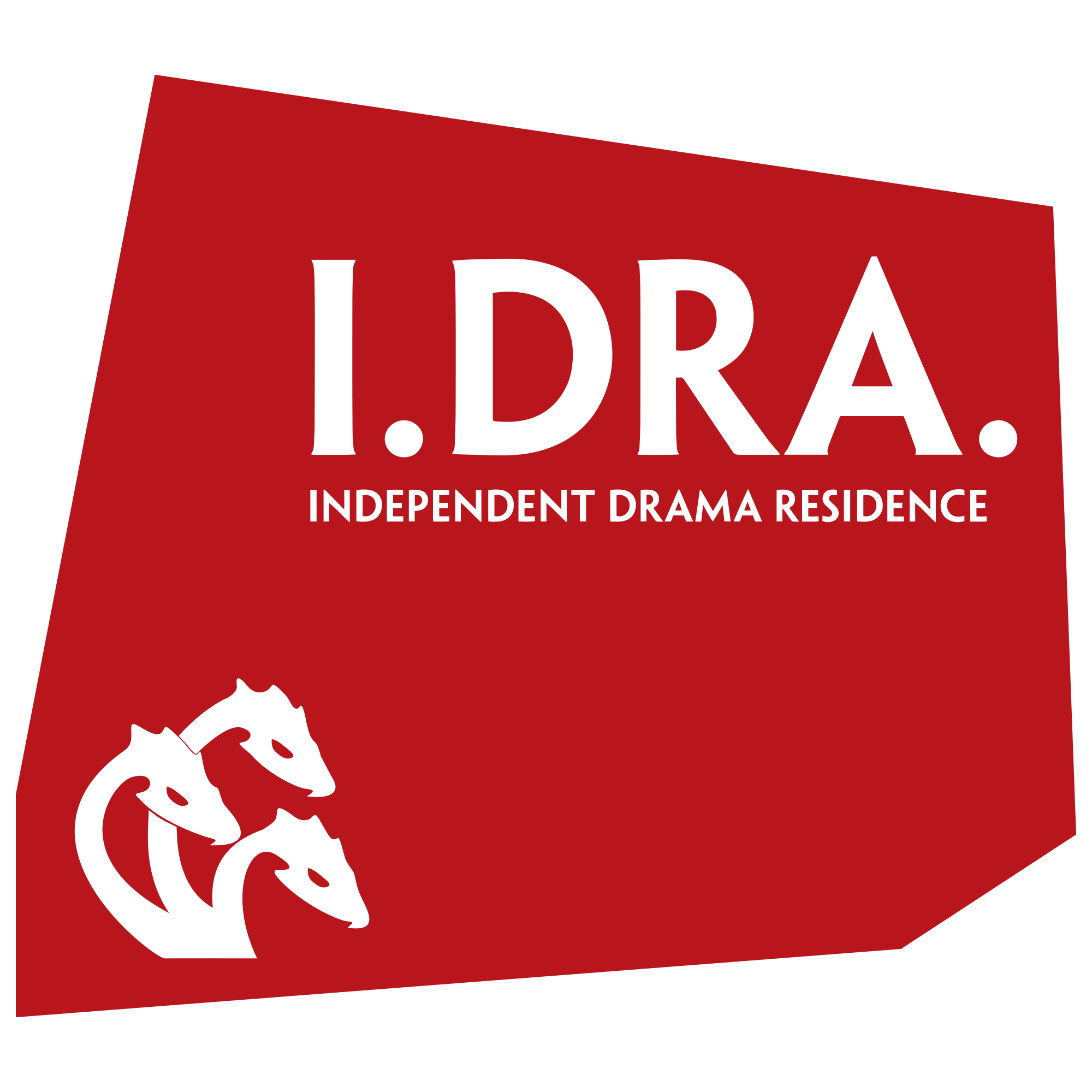Mentre in Europa si combatte una battaglia feroce per il finanziamento alla cultura al fine di mantenerne l’indipendenza e il valore, in Italia la battaglia è già persa. Il “male minore” è un concetto che si ritrova in vari contesti filosofici e politici. Niccolò Machiavelli sosteneva la necessità di riconoscere e affrontare i problemi scegliendo l’opzione meno dannosa. Antonio Gramsci ha discusso l’idea del “male minore” nei suoi Quaderni dal carcere, sottolineando come qualsiasi male possa essere considerato minore rispetto a uno potenzialmente peggiore che potrebbe seguire. Il concetto è anche legato a riflessioni etiche e politiche, come quelle di Hannah Arendt, che lo considerava una questione cruciale nel contesto degli “interventi umanitari” e delle atrocità belliche.
Mi chiedo quindi cosa significa “il male minore” per le organizzazioni rappresentative?
Durante un incontro organizzato da IETM a Berlino, ho ascoltato un’intervista a un operatore culturale che negli ultimi anni ha resistito in Polonia. Ho preso appunti e più guardavo la persona, più mi rendevo conto di quanto alcune pratiche di cui parlava fossero simili a quelle italiane:
- Controllo statale e censura: il governo ha aumentato il controllo sulle istituzioni culturali nominando figure fedeli ai propri ideali e riducendo l’autonomia decisionale. Ciò ha portato a un aumento della censura e dell’autocensura, con artisti/e e operatori/operatrici culturali che evitano argomenti o espressioni che potrebbero non piacere a chi detiene il potere. In Italia, purtroppo, questo è già successo, seguendo gli stessi metodi utilizzati dai governi precedenti.
- Tagli ai finanziamenti: i fondi statali per la cultura sono stati ridotti, danneggiando le organizzazioni e gli/le artisti/e indipendenti che legano la loro sopravvivenza a questo sostegno. In Italia, nonostante il numero di richiedenti idonei al Fondo Nazionale per gli Spettacoli dal Vivo sia aumentato nel 2025, il budget complessivo è rimasto invariato. Di conseguenza, le singole organizzazioni stanno subendo tagli significativi.
- Reindirizzamento dei fondi verso soggetti “amici”: le leggi, svuotate, introducono parametri di valutazione del tutto incompatibili con gli obiettivi dichiarati, favorendo una visione strettamente commerciale del teatro o addirittura di specifiche organizzazioni. Lo stesso avviene in Italia.
- “Frecciatine” attraverso l’istruzione: solo alcuni attori culturali chiave sono stati esclusi, come monito per gli altri. In Italia, questo è appena successo con la selezione delle organizzazioni ai sensi del nuovo decreto ministeriale.
- Manipolazione ideologica: il governo ha cercato di promuovere una narrazione specifica della storia e dell’identità nazionale, spesso attraverso eventi culturali e mostre che glorificano il nazionalismo e il conservatorismo. Ciò ha creato un clima culturale in cui le voci dissenzienti o critiche sono emarginate. In Italia, questo processo è per ora parziale ma, con l’approvazione del nuovo Codice della Cultura il prossimo anno, potrebbe essere completato.
- Attacchi alla libertà di espressione: il governo ha preso di mira artisti/e e giornalisti/e che hanno osato criticare le sue politiche, ricorrendo ai tribunali e a campagne diffamatorie per intimidirli/e e metterli/e a tacere. Questo avviene solo in parte in Italia, ci sono però casi emblematici come quelli di Roberto Saviano (Fiera del Libro di Francoforte) e di Elio Germano (Cinema).
- Riorganizzazione delle istituzioni culturali: le istituzioni sono state riformate per riflettere la visione del governo, rimuovendo figure chiave e promuovendo personale ideologicamente allineato. In Italia, si è verificata una certa riorganizzazione delle direzioni ministeriali, è un piano ancora in corso e non una fase completata.
- Fuga di cervelli: molti/e artisti/e e operatori/operatrici culturali hanno lasciato il Paese a causa del clima repressivo e della mancanza di opportunità, con conseguente perdita di capitale intellettuale. In Italia è sempre stato così, forse semplicemente non ce ne accorgiamo più.
Possiamo quindi dare un’occhiata alla situazione attuale in Italia, che sta assistendo all’erosione – non proprio graduale – di un sistema che, sebbene imperfetto, era comunque basato su principi democratici.
I fatti:
- Luglio 2025: AGIS (la più grande associazione rappresentativa del settore) ha deciso di rimanere al tavolo delle trattative con il governo anche dopo che parole – e quindi concetti – come “rischio culturale” sono stati eliminati, devastando il settore del teatro contemporaneo.
- Settembre 2025: C.Re.S.Co. (con le sue oltre 250 organizzazioni e reti) è stata silenziosamente rimossa dalle trattative, ritenuta politicamente scomoda.
- Metà giugno 2025: 3 dei 7 membri della commissione teatrale si sono dimessi. I restanti quattro, tutti nominati politicamente, hanno continuato a valutare la qualità dei progetti e hanno approvato le decisioni a maggioranza.
- Fine giugno 2025: sono pubblicati i risultati del finanziamento triennale 2025, con tagli alle organizzazioni più innovative, in particolare nei settori della danza e del multidisciplinare. I punteggi del settore contemporaneo sono estremamente bassi (per i numeri precisi, si rimanda alla pubblicazione C.Re.S.Co. del 18 luglio).
Se confrontiamo la situazione italiana con la cronologia polacca, ora siamo al punto 5 su 8.
Chiediamo ora alle organizzazioni rappresentative: qual è il male minore tra “le frecciatine educative” e la manipolazione ideologica? Si può davvero scegliere tra i due? O è ora di introdurre un approccio diverso? Mettiamola così: ho un figlio e una figlia. Se dovessi spingere uno dei due giù da una torre, chi sceglierei per primo? Qual è il male minore? Forse la risposta è: non spingo nessuno dei due. Forse la risposta è: abbiamo bisogno di una linea rossa, che identifichi valori semplici e chiari al di sotto dei quali non dobbiamo mai scendere. Ad esempio: trasparenza nelle valutazioni e diversità culturale. Questo sarebbe un passo avanti. Ma richiede anche maturità da parte delle organizzazioni: non è facile abbandonare la logica di sopravvivenza del “mors tua, vita mea” tipica del classico lobbying, e passare a una visione collettiva del bene comune, che potrebbe guidare la convergenza e l’unione di tutti coloro che si oppongono.
Il 7 luglio, a seguito delle decisioni di finanziamento, si è tenuta una riunione su Zoom con oltre 1.000 organizzazioni provenienti da tutta Italia, un numero mai visto prima. La qualità della discussione, sebbene preparata con cura, rifletteva lo stato di un animale colpito alla testa con una pala: analisi di ciò che era accaduto, rimpianto per non averlo visto prima, visione offuscata di un futuro di vendetta. Ed è comprensibile, lo shock è stato forte. Ma ciò che è emerso chiaramente è stata la necessità di definire una strategia comune. Quale dovrebbe essere questa strategia? In quella riunione di IETM, che ora sembra profetica, sono state proposte tre strategie:
- Convergenza: trovare un terreno comune tra tutte le componenti della vita culturale, compreso l’allineamento con le associazioni del settore sociale e assistenziale che condividono valori simili.
- Creare/mantenere canali di comunicazione istituzionali aperti: mantenere vivo il dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. Non stuzzicare ma informare costantemente.
- Rafforzare gli sforzi di comunicazione: utilizzare sia azioni accattivanti che massicce campagne sui social media per raggiungere i media mainstream.
Certo, questa è l’Italia. E in questo contesto, deliberatamente frammentato e quindi fragile, questo potrebbe sembrare pura utopia.
Articolo scritto dal direttore artistico Davide D’Antonio.
Traduzione dall’inglese