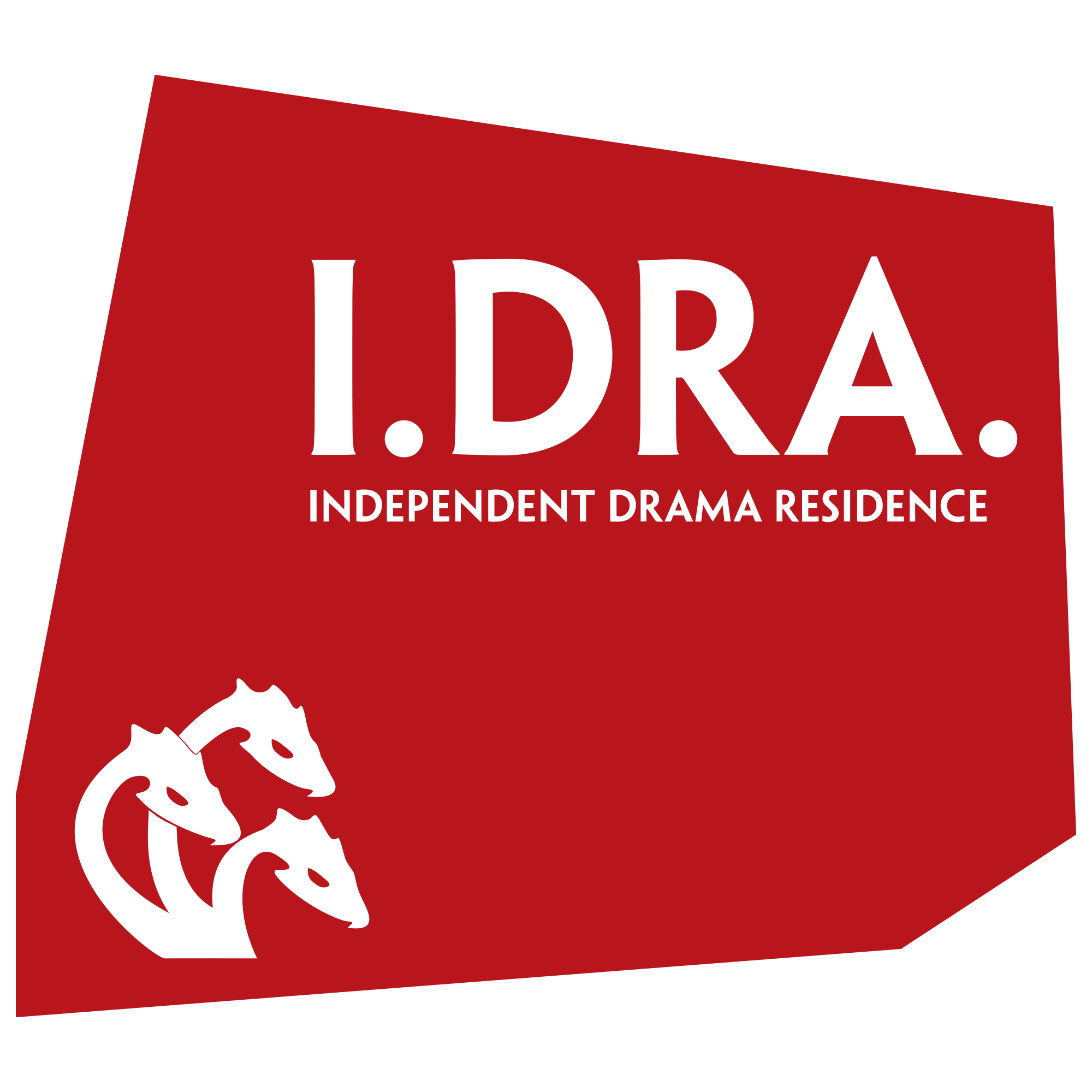Diversi amici e amiche mi hanno chiamato per capire cosa sta succedendo in Italia di così eccezionale perché echi stanno arrivando alla stampa internazionale. Ho quindi deciso di scrivere questo articolo su fatti ancora in corso, per cui mi scuso in anticipo se non sono completi.
Negli ultimi trent’anni, il sistema teatrale italiano è stato progressivamente indebolito dall’instabilità istituzionale, dalle pressioni economiche e dalle interferenze politiche. La situazione attuale è il risultato non solo di un cronico sottoinvestimento e di scelte politiche sbagliate, ma anche di un cambiamento più preoccupante nella filosofia stessa alla base della governance culturale nazionale. Le recenti dimissioni di tre commissari della commissione teatrale del Ministero della Cultura, in segno di protesta contro il declassamento del Teatro della Pergola (diretto dal noto drammaturgo Stefano Massini) a Firenze, hanno cristallizzato un momento di crisi istituzionale e democratica. Al centro della crisi c’è una trasformazione fondamentale del modo in cui il teatro viene valutato e apprezzato in Italia.
REWIND…
Nel 1985, la creazione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) ha segnato l’impegno istituzionale di promuovere il teatro come forma di produzione culturale a lungo termine e socialmente radicata. Ma questa visione è stata presto abbandonata. Già nel 1987 il sistema è tornato ai cicli di finanziamento annuali, che hanno reso i teatri vulnerabili alla volatilità politica e alle recessioni economiche. Nel corso del tempo, questo modello di finanziamento ha scoraggiato la sperimentazione e ha reso più profondo il divario tra le istituzioni “ufficiali” più grandi e quelle più piccole, innovative o periferiche.
La legge “Valore Cultura” del 2013 e la sua attuazione tramite il decreto sul teatro del 2014 hanno introdotto un sistema di valutazione basato sui dati. Il numero di spettacoli, i biglietti venduti e l’autonomia finanziaria sono diventati i parametri principali per il finanziamento pubblico. Ciò ha incentivato la quantità rispetto alla qualità, la dimensione rispetto alla profondità e la pianificazione a breve termine rispetto alla crescita artistica a lungo termine. I teatri che non erano in grado di fornire grandi numeri, spesso quelli che producevano opere sperimentali o socialmente impegnate, sono stati di fatto emarginati.
Nel 2024 le norme del FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) sono state nuovamente riviste. Il nuovo quadro normativo ha introdotto elementi di concorrenza ancora più forti, allineando la valutazione culturale ai principi di mercato. Sebbene presentata come una mossa verso l’efficienza e la “meritocrazia”, questa riforma ha segnato un cambiamento radicale nella filosofia culturale: dal teatro come strumento per costruire coesione sociale a livello nazionale al teatro come prodotto di intrattenimento valutato in base a prestazioni competitive. Questo cambiamento ha sostituito la visione della cultura come bene pubblico – destinato a educare, stimolare e unificare – con un quadro più vicino a quello del settore privato, dove il numero di spettatori/spettatrici, il marchio e le prestazioni manageriali prevalgono sull’impatto sociale, la diversità e l’innovazione.
E ORA
In questo contesto, istituzioni come il Teatro della Pergola, a lungo celebrate non solo per la loro qualità artistica ma anche per il loro ruolo civico ed educativo, sono diventate vulnerabili alla svalutazione quando giudicate secondo standard puramente competitivi e di stampo commerciale. Il Teatro della Pergola è stato declassato da “Teatro Nazionale” a ente di livello locale, con il rischio di perdere fino a € 400.000 di finanziamenti annuali. In segno di protesta, tre commissari non nominati dal governo, in rappresentanza delle regioni, dei comuni e delle associazioni di settore, si sono dimessi dalla commissione teatrale. Hanno denunciato la decisione come ideologicamente motivata, opaca e ingiustificata.
Il Ministero della Cultura ha deciso di procedere comunque con questa decisione, invocando il principio di maggioranza. Ma la maggioranza è ora composta interamente da membri nominati politicamente, senza alcuna rappresentanza da parte di enti culturali locali o indipendenti. In un sistema che un tempo si vantava del pluralismo e della sussidiarietà, questo cambiamento è profondamente preoccupante. Sebbene tecnicamente legale, la decisione del Ministero rivela una preoccupante erosione dei principi democratici nella politica culturale. La composizione della commissione FNSV era stata concepita per riflettere l’equilibrio territoriale e l’autonomia professionale, con le voci dei governi locali e delle organizzazioni di settore che garantivano la responsabilità e la diversità. Rendendo queste voci irrilevanti attraverso il dominio della maggioranza politica, il Ministero sta di fatto trasformando la governance culturale in uno strumento di parte. Ciò non solo mina la fiducia nel sistema, rischia anche di ridurre le istituzioni culturali a meri strumenti di approvazione politica e produzione commerciale. Un teatro che soddisfa solo i gusti del potere o del mercato non può adempiere al suo ruolo storico di spazio di dialogo, dissenso e riflessione collettiva.
Quello che sta accadendo a Firenze non è un errore burocratico isolato. È il logico punto di arrivo di decenni di abbandono strutturale, fragilità economica e, ora, conversione ideologica della cultura. Il passaggio dalla “cultura come infrastruttura civica” alla “cultura come intrattenimento competitivo” non è solo una questione tecnica: è un cambiamento di paradigma con profonde implicazioni democratiche. La crisi del Teatro della Pergola potrebbe essere ricordata come un punto di svolta – verso un’ulteriore erosione o una necessaria rifondazione della visione culturale italiana.
Come ha recentemente commentato C.Re.S.Co.,l’associazione più rappresentativa dei teatri indipendenti in Italia: “La cosa positiva è che se il teatro è tornato a essere un campo di battaglia per la politica significa che mantiene ancora un ruolo importante nella società. La cosa negativa è tutto il resto”.
Postscriptum
Le dichiarazioni del sottosegretario del MIC Gianmarco Mazzi sono probabilmente da accogliere positivamente: «Entro pochi giorni istituiremo un gruppo di lavoro per lo studio e l’individuazione di nuovi criteri e nuovi metodi per l’assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo che lavorerà per i prossimi due anni e dovrà creare un sistema più semplice e trasparente di quello attuale, da lasciare in eredità alla prossima legislatura. Giorgio Assumma guiderà il gruppo di studio che si avvarrà del contributo dei più autorevoli studiosi italiani della materia e dei migliori operatori del mondo dello spettacolo».
Vedremo quindi presto (sì, «presto», perché due anni per la burocrazia italiana sono una decisione rapida!) in quale direzione andremo. To be continued…
Articolo scritto dal direttore artistico Davide D’Antonio.
Traduzione dall’inglese