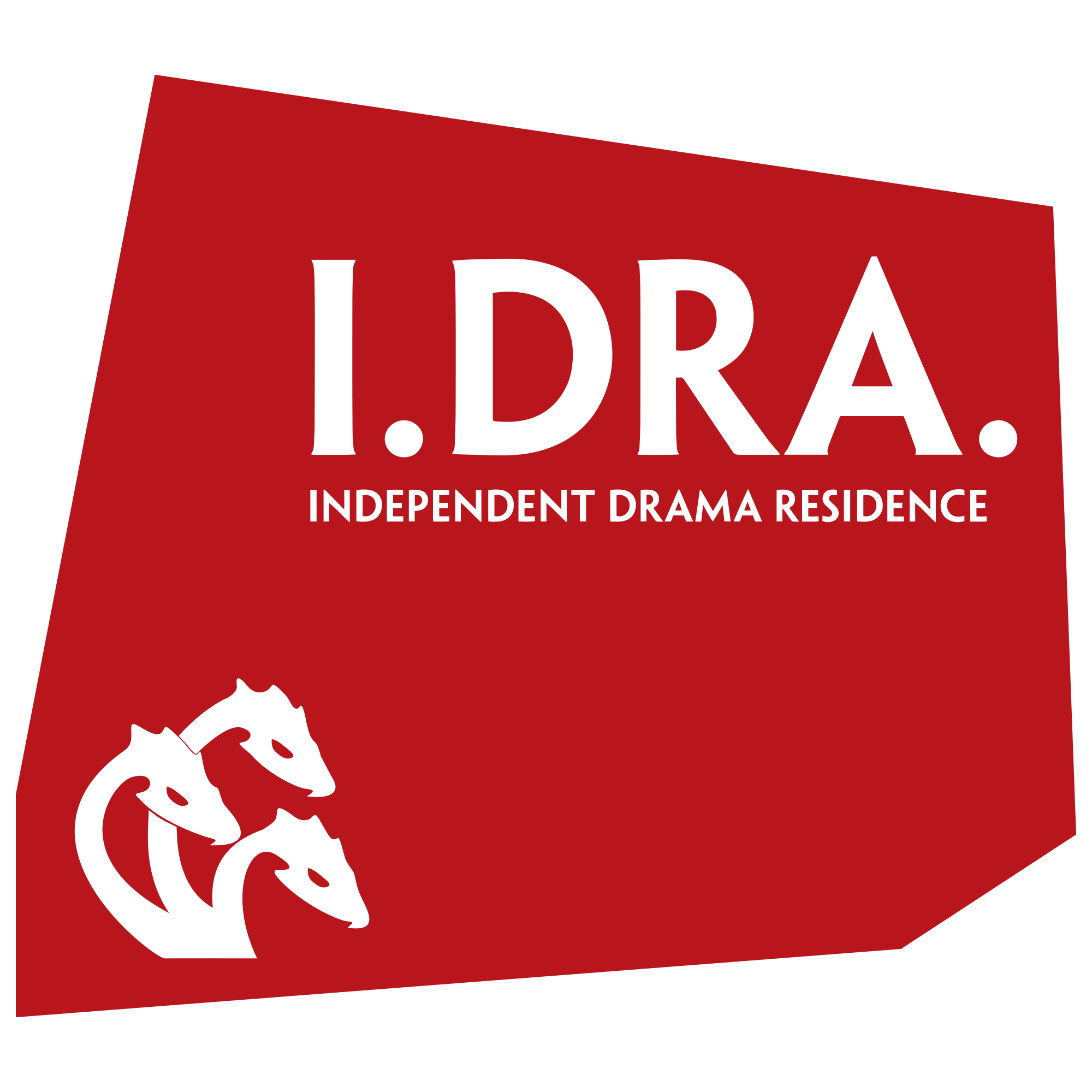Recentemente sono stato invitato a partecipare al panel introduttivo di Trans Europe Hall sulle residenze artistiche, intitolato Home (‘casa’). Devo ammettere che ho trovato difficile inquadrare il concetto di “casa” nel contesto delle residenze perché l’idea di “casa” sta sempre più cambiando. Grazie alla creazione di uno spazio condiviso all’interno della comunità europea, le persone hanno sviluppato una crescente capacità di muoversi liberamente. Cosa significa “casa” per una persona come me, un operatore culturale che trascorre solo due giorni alla settimana nella sua vera casa in Italia e vive costantemente in altre case temporanee? Ma non si tratta solo di mobilità fisica. C’è anche la dimensione digitale che smaterializza la nostra presenza e ci permette di abitare virtualmente case diverse. E che dire dell’esperienza delle comunità di migranti per le quali “casa” è sia uno spazio fisico che un contenitore di ricordi, esperienze e cultura del loro paese d’origine? Alla luce di queste riflessioni, credo che le residenze siano, e continueranno a essere, il contesto più adatto per sostenere gli artisti e le artiste in questa era trans-locale. Offrono uno spazio in cui identità fluide possono incontrarsi, favorendo ambienti di sperimentazione e condivisione, piuttosto che limitarsi a produrre risultati ben confezionati e facilmente commercializzabili.
Partendo da questa premessa, mi è stato chiesto di raccontare le residenze italiane e così ho fatto.
Le residenze artistiche italiane possono essere inserite nel quadro sviluppato dalla Comunità europea negli ultimi anni e sono state anche fonte di ispirazione per la Comunità stessa nella definizione del nuovo quadro. La visione europea delle residenze artistiche è incentrata sulla promozione della mobilità culturale e sulla promozione degli scambi creativi tra artisti e artiste di diverse nazionalità. Secondo il Policy Handbook on Artists’ Residencies (‘Manuale delle politiche sulle residenze artistiche’) (2014), le residenze artistiche sono strumenti fondamentali per l’integrazione sociale, la diversità culturale e l’innovazione. Il programma Culture Moves Europe (2022) riflette l’impegno dell’Unione Europea a sostenere la mobilità degli artisti e delle artiste fornendo finanziamenti per incoraggiare la loro partecipazione a residenze in tutta Europa. La Carta delle Residenze Artistiche (2019), redatta a Matera, sottolinea l’importanza di questi spazi non solo per la crescita individuale degli/delle artisti/e ma anche per il rafforzamento delle comunità locali attraverso il dialogo e lo scambio culturale. La visione europea sostiene l’idea che le residenze artistiche siano essenziali per la crescita della creatività, la creazione di reti internazionali e l’affermazione della cultura europea come valore condiviso. Uno degli aspetti più notevoli del sistema italiano delle residenze è la sua capacità di accogliere diverse visioni su ciò che una residenza può e deve essere. Alcune sono profondamente radicate nella ricerca performativa e nella sperimentazione artistica, altre enfatizzano l’impegno sociale e l’interazione con il pubblico, altre ancora si concentrano sulla produzione, la formazione e lo scambio interdisciplinare.
L’Europa presenta una grande varietà di modelli, ciascuno dei quali è il risultato di diversi contesti culturali, politici e istituzionali:
- In Francia il sistema delle residenze è fortemente influenzato dalla politica culturale nazionale. Istituzioni come il Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public o le Résidences territoriales sono spesso inserite in programmi pubblici a lungo termine con mandati chiari in materia di accessibilità, decentralizzazione e democratizzazione culturale. La struttura tende ad essere centralizzata con un forte finanziamento pubblico e una visione nazionale a guida delle pratiche locali.
- In Belgio, in particolare nelle Fiandre, il modello è più incentrato sulla figura dell’artista e flessibile. Residenze come WP Zimmer, Kunstencentrum BUDA o Vooruit danno grande importanza al processo piuttosto che al prodotto, offrendo agli/alle artisti/e spazio e tempo senza richiedere risultati immediati. Il sistema è meno gerarchico e spesso intrecciato con iniziative indipendenti, promuovendo uno spirito di sperimentazione e corresponsabilità tra artisti/e e istituzioni.
- In Germania il panorama è ricco ed eterogeneo, a riflesso della natura federale del Paese. Esistono residenze istituzionali ben finanziate, come quelle ospitate dai principali teatri o fondazioni culturali e, allo stesso tempo, residenze promosse da iniziative locali, inserite in progetti di rigenerazione urbana o di sviluppo comunitario. Si pone una forte enfasi sull’interdisciplinarità, sulla sostenibilità e, spesso, sull’impegno politico.
In questo contesto, il modello italiano emerge come un ibrido: riunisce la missione pubblica del sistema francese, l’autonomia artistica della scena belga e la diversità strutturale del quadro tedesco, e lo fa all’interno di un approccio cooperativo e negoziato unico nel suo genere. Grazie all’accordo Stato-Regioni e alle linee guida condivise introdotte con l’articolo 43, l’Italia è riuscita ad armonizzare un sistema frammentato, mantenendo al contempo spazio per l’innovazione, l’identità e la sperimentazione a livello locale. Questa capacità di combinare visioni multiple, di tenere insieme le differenze in una tensione produttiva, è forse l’elemento più esportabile dell’approccio italiano: un modello di federalismo culturale, costruito non su un’imposizione dall’alto ma sulla fiducia, sul dialogo e sulla responsabilità condivisa.
Le residenze artistiche italiane sono più che semplici spazi fisici: sono incubatori di creatività, laboratori di innovazione e ponti tra tradizione e sperimentazione. Offrono agli artisti e alle artiste l’opportunità di esplorare, creare e collaborare, favorendo lo scambio di idee e arricchendo il tessuto artistico del nostro Paese. Il sistema di finanziamento delle residenze artistiche in Italia è caratterizzato da un modello decentralizzato e collaborativo, basato su un Accordo Stato-Regioni e regolato dall’Articolo 43 del Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017.
Caratteristiche principali:
- Cofinanziamento tra Stato e Regioni
- Assegnazione basata su bandi
- Cicli di programmazione triennali
- Standard minimi e monitoraggio
- Flessibilità e adattamento locale
- Tipi di attività ammissibili
Grazie a un accordo nazionale tra Stato e Regioni, il sistema delle residenze artistiche si estende ora su 19 regioni italiane, formando una vivace rete di oltre 62 centri dedicati alla ricerca e alla creazione artistica. Ogni residenza è unica e riflette la storia, la geografia e l’identità culturale del proprio territorio. Che si trovino in centri urbani o in paesaggi rurali, le residenze fungono da centri dinamici per la produzione artistica, l’innovazione e il dialogo interdisciplinare. I dati di monitoraggio evidenziano un impatto crescente: artisti/e provenienti da diversi background e discipline trovano nelle residenze un terreno fertile per la sperimentazione, che porta allo sviluppo di nuovi linguaggi artistici e performance che sfidano le convenzioni e superano i confini.
Alcuni dati raccolti negli anni:
- costo medio annuale di una residenza artistica: 55.000,00 (AiR) – 250.000 (centro di residenza)
- costo totale per lo Stato: € 2 milioni + costo totale per Regione: € 3 milioni = costo totale € 5 milioni
- numero di artisti/e ospitati/e: 950
- numero di giorni lavorativi per artisti/e: 5700 > € 3.451.868
- numero di spettacoli aperti dopo la residenza: 187
- numero di dipendenti: 766
Per maggiori dettagli: www.residenzeartistiche.it
Cosa sono diventate le residenze?
- Luoghi trans-locali: agire localmente, pensare globalmente: anche le residenze artistiche italiane sono un esempio di trans-località, luoghi in cui il locale incontra il globale. Le residenze sono profondamente radicate nei loro territori ma aperte a influenze esterne. Le collaborazioni internazionali, i programmi di scambio e le iniziative di mobilità degli/delle artisti/e rendono questi spazi terreno fertile per il dialogo interculturale. Le residenze diventano così nodi di una rete globale dove le pratiche artistiche sono costantemente arricchite dalla circolazione di idee, corpi e storie. Ci mostrano che “internazionale” non significa astratto o scollegato ma ancorato, situato e relazionale.
- Un motore per la crescita professionale e lo sviluppo strutturato: Al di là del loro valore artistico e sociale, le residenze sono piattaforme per strutturare carriere. Offrono agli/alle artisti/e visibilità, tutoraggio e connessione a reti più ampie di produzione e diffusione. Sono spazi di professionalizzazione (non in senso burocratico) perché consentono agli artisti e alle artiste di crescere in modo responsabile, etico e creativo. Questo approccio strutturato alle residenze è una delle caratteristiche più esportabili del modello italiano: la combinazione di libertà artistica e rigore organizzativo, di cura del processo creativo e di attenzione al più ampio ecosistema culturale.
- Una trasformazione radicale condivisa, anche nell’estetica, caratterizzata dalla collaborazione intergenerazionale per rinnovare i linguaggi espressivi, in netto contrasto con un Paese in cui le persone giovani hanno spesso dovuto sovrastare i propri padri per lasciare il segno.
Cosa è esportabile del modello italiano?
L’esperienza italiana offre spunti preziosi alla comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda la strutturazione dei programmi di residenza. Ciò che contraddistingue il sistema italiano è la sua combinazione unica di riconoscimento formale, governance decentralizzata e rispetto dell’autonomia artistica. Attraverso l’articolo 43, l’Italia ha istituito un quadro giuridico e istituzionale che definisce le residenze come parte dell’infrastruttura culturale pubblica. Ciò conferisce alle residenze visibilità, legittimità e accesso a opportunità di finanziamento a lungo termine. Allo stesso tempo, il sistema rimane flessibile e reattivo, consentendo a ciascuna residenza di definire la propria missione e i propri metodi in dialogo con le comunità locali e le esigenze artistiche. Questo duplice approccio – un chiaro mandato pubblico combinato con l’indipendenza operativa – è ciò che rende esportabile il modello italiano. Dimostra come i governi possano sostenere le residenze non imponendo uniformità ma consentendo la diversità all’interno di un quadro condiviso. L’Italia sostiene inoltre un riconoscimento basato su criteri (e non categorie rigide) che incoraggiano la qualità, la trasparenza e l’apprendimento reciproco senza imporre standardizzazione. Inoltre, il modello di governance collaborativa che coinvolge sia lo Stato sia le Regioni garantisce che le politiche siano concrete, inclusive e attente alle specificità territoriali. Esportare il modello italiano non significa replicarlo in maniera identica in altri contesti ma abbracciarne i principi: pluralismo, sussidiarietà, corresponsabilità e visione a lungo termine. Si tratta di valori che possono ispirare altre nazioni a costruire sistemi di residenza solidi, inclusivi e sostenibili.
Le residenze artistiche non operano in modo isolato ma interagiscono con l’ambiente circostante, infondendo nuova vita alle comunità e ai territori. Offrono opportunità uniche per colmare il divario tra artisti/e e pubblico, favorendo una comprensione e un apprezzamento più profondi delle arti. Attraverso workshop, prove aperte e performance site-specific, le residenze invitano il pubblico a partecipare al processo creativo, abbattendo le barriere artista-spettatore/speattratrice.
I vantaggi sono molteplici:
- Gli/Le artisti/e acquisiscono tempo, spazio e risorse per sviluppare il proprio lavoro, entrare in contatto con colleghi/e e impegnarsi in dialoghe significativi.
- Il pubblico non è solo spettatore, ma partecipante, cresce insieme ai progetti e spesso diventa co-creatore.
- La cittadinanza e le comunità locali sperimentano in prima persona come l’arte possa favorire il senso di appartenenza, l’identità e nuovi modi di immaginare il mondo.
Principi per un programma di residenza di successo
Quando riflettiamo su ciò che rende un programma di residenza efficace, dobbiamo sostenere alcuni principi fondamentali:
- Centralità artistica, gli/le artisti/e devono essere sostenuti e non strumentalizzati.
- Apertura alla diversità per consentire la coesistenza di varie espressioni artistiche e culturali.
- Impegno territoriale per fare in modo che le residenze interagiscano in modo significativo con i contesti locali.
- Visione internazionale per promuovere la mobilità, lo scambio e l’apprendimento oltre i propri confini.
- Sostenibilità sia ambientale sia organizzativa.
- E soprattutto, resilienza, la capacità di adattarsi, trasformarsi e continuare nonostante l’incertezza.
La resilienza è una delle qualità più ammirevoli delle residenze artistiche. Anche in tempi di crisi – economica, politica o sociale – le residenze hanno trovato il modo di reinventarsi, di rimanere rilevanti, di rispondere alle nuove urgenze senza perdere di vista la loro missione.
Articolo scritto dal direttore artistico Davide D’Antonio.
Traduzione dall’inglese